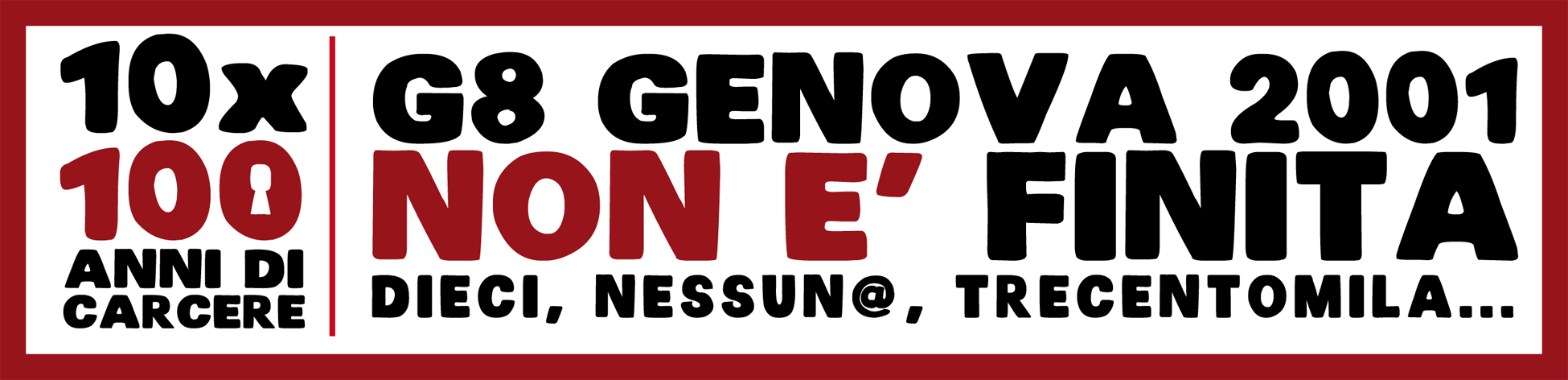200 mln in meno alle università pubbliche, duecento mln in più alle università private! Questa la finanziaria del governo per l'università! Cosa potevamo aspettarci dal governo della Bocconi? L'istruzione annega in un mare d'austerità!
La stessa corrente che da decenni devasta le risorse pubbliche e i nostri salari a favore di banche, imprese e profitti privati sta uccidendo la scuola e l'università pubblica! L'istruzione privata non dovrebbe ricevere un euro dalle casse pubbliche che tutti e tutte noi alimentiamo con tasse altissime senza uno straccio di servizio funzionante e con una didattica sempre più inutile. D'altronde dal governo dei banchieri e dei professori della Bocconi non poteva esserci discontinuità in una politica di spostamento di fondi iniziata negli anni '80 e accelerata dallo scoppio della crisi.
Sono soldi nostri, soldi dell'istruzione pubblica!
Basta regali agli squali, riprendiamoci tutto!
Sulla Spending Review del governo...
a cura di Sbilanciamoci
Si risparmierebbero 700 milioni se si cancellassero i sussidi pubblici che ogni anno vengono erogati alle scuole e alle università private del nostro paese, cattoliche e non solo. Negli ultimi 10 anni sono più di 5 i miliardi di euro che se ne sono andati verso il privato a scapito dell'università e della scuola pubblica, la cui condizione è quella che ben conosciamo.
Come se non bastasse, metà delle scuole pubbliche italiane non rispetta le normative antisismiche, antincendio e non ha il certificato di idoneità statica. Due terzi degli studenti universitari che avrebbero diritto ad una borsa di studio per potersi iscrivere all'università (cioè sono dichiarati idonei) non ricevono nemmeno un euro perché incredibilmente ci sono i bandi ma non ci sono i soldi. Mentre in Francia e in Germania gli studenti che usufruiscono delle borse di studio sono il 25%, in Italia la percentuale scende all'8%. Sarà un caso, ma i laureati in Italia sono il 19% della popolazione giovanile, mentre nell'Unione Europea la media è del 30%.
Lo stesso vale per le residenze universitarie: non ci sono alloggi pubblici per gli studenti e così prolifera il mercato nero degli affitti e i costi per le famiglie si moltiplicano.
Nonostante questo - nonostante i problemi di spesa pubblica - i governi di centrodestra e di centrosinistra si sono permessi di spendere 5 miliardi di euro in 10 anni per far sopravvivere le scuole private (sostenendo gli istituti religiosi) e aiutare le famiglie di chi - avendo redditi elevati - manda i propri figli alle scuole e all'università a pagamento. Meglio cancellare questi sussidi oppure usarli per la scuola pubblica e il diritto allo studio.
Salvatore Cannavò da Ilfattoquotidiano.it
Tra le principali misure di tagli presentati dal governo ai sindacati leggiamo: taglio del personale del pubblico impiego del 10% per i dipendenti e del 20% per i dirigenti. Per due anni, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, lo stipendio dei dipendenti delle società pubbliche non potrà superare quello del 2011 mentre si bloccano le assunzioni dell’80% dal 2012 al 2014 e poi del 100%.
Come non bastasse si riducono ancora, dopo anni e anni in cui lo si fa, i trasferimenti agli Enti locali di 700 milioni per il 2012 che salgono a 1 miliardo dal 2013. Il Fondo sanitario viene ridotto di 3 miliardi. E in tutto questo sferruzzare di tagli il governo riesce a inserire anche 200 milioni aggiuntivi per finanziare le scuole private. Togliendoli, ovviamente, alla ricerca e all’università pubblica.
Si potrebbe ironizzare facilmente ricordando le misure di Tremonti, Brunetta e Gelmini. Si può fare molta nota politica cercando di cogliere le resistenze dei partiti, i malumori del Pd, l’ira dei sindacati (faranno davvero lo sciopero generale?). Quello che vale la pena sottolineare, però, è la direzione di marcia del governo, la volontà espressa da Monti.
E mettere tutto questo a confronto con questa frase: «In un nuovo centrosinistra europeo Monti può trovarsi a perfetto agio. È una personalità liberale che con la sua azione può mitigare positivamente le resistenze stataliste che ci sono ancora tra i socialisti. La sua insistenza sul completamento del mercato unico è giusta. Ha posizioni che a me paiono compatibili con il nostro orizzonte programmatico». Lo ha detto Massimo D’Alema sabato scorso in una intervista al Corriere della Sera, peraltro molto discussa.
Le cose sono due: o D’Alema di politica non capisce nulla oppure il “suo” orizzonte programmatico è davvero disastroso. Abbiamo il sospetto, però, che entrambe le affermazioni siano vere.
L'orgia clientelare
di Francesco Piccioni
Se l'amministrazione pubblica non possiede al suo interno determinate competenze può ricorrere a consulenze esterne, pagate ovviamente con criteri di mercato. In teoria non ci sono obiezioni; in pratica è l'escamotage con cui vengono nutrite clientele politico-imprenditoriali di dimensioni spesso arbitrarie. Tra i «consulenti» possiamo trovare un Enrico Bondi (chiamato a governare proprio la spending review, sembra a titolo gratuito) o un Peppe Dimitri, ex terrorista dei Nar infine morto in un incidente stradale, assunto da Gianni Alemanno quando faceva il mistro dell'agricoltura. Tra questi due livelli si muove un «mare magnum» di figure varie, possibile solo grazie alla facoltà di «nominare» qualcuno senza alcun riscontro di competenza curriculare. Niente da obiettare sulle abilità di Bondi, per restare all'esempio (pur senza dover per questo condividerne le scelte); ma di Dimitri nessuno conosceva almeno una passioncella per il giardinaggio da balcone. Anche in questo caso l'indebolimento del «pubblico» è diventato occasione di arricchimenti «privati», senza peraltro elevare di un millimetro le capacità funzionali. Per eliminare dalla spesa «sprechi e ruberie», in questo ambito, si dovrebbe incentivare la formazione in house delle competenze necessarie e vincolare la richiesta di consulenze esterne all'obbligo di curricula certificati. Naturalmente, dovrebbe esser prevista la condanna al risarcimento integrale all'ente danneggiato (interessi compresi) da parte dell'amministratore pubblico beccato ad «elargire» una consulenza truffaldina a qualche «amico». Se si vuol battere un malcostume, non serve tagliare linearmente (i «raccomandati» si salverebbero lo stesso), ma sanzionare in base a regole e controlli persuasivi.
SPESE MILITARI
La truppa è troppa
a cura di Sbilanciamoci.
Quattro miliardi e 623 milioni in un anno: è l'ammontare delle risorse che potrebbero essere recuperate riducendo le spese militari in Italia nel 2012. Il bilancio della Difesa per quest'anno è pari a 19,895 miliardi di euro, di cui quasi quindici destinati al sovvenzionamento di esercito, marina ed aeronautica, con una crescita del 4,4% rispetto al 2011 dettata principalmente dall'aumento dei costi per il personale. A proposito del personale: in Italia ci sono oggi ben 180.000 militari. Non solo: il numero di comandanti è superiore a quello dei comandati. Tre miliardi di euro potrebbero entrare in cassa decurtando le forze armate di 60.000 unità, portandole così dalle attuali 180.000 a 120.000. Altri 783 milioni di euro potrebbero venire per il 2012 dalla riduzione dei «Programmi d'arma», con la cancellazione degli impegni per la produzione di 90 cacciabombardieri F35 (complessivamente ci costeranno 10 miliardi di euro) e dei finanziamenti previsti quest'anno per la costruzione di 4 sommergibili Fremm e delle due fregate «Orizzonte».
748 milioni di euro potrebbero poi pervenire dal ritiro delle truppe italiane dalla missione in Afghanistan. Inoltre, 72 milioni di euro verrebbero incamerati se si ponesse termine alle operazioni, sbagliate, di pattugliamento delle nostre città ad opera del personale delle forze armate. L'abolizione della cosiddetta mini-naja (cioè del programma «Vivi le Forze Armate, militare per tre settimane») porterebbe in cassa altri 20 milioni.
In tutto 4,62 miliardi da destinare subito, appunto, a usi decisamente più «civili», come il servizio civile nazionale, sovvenzionato con 299 milioni di euro nel 2008 e soltanto 68 nel 2012, e la cooperazione, il cui finanziamento pubblico è stato praticamente azzerato.
SANITÀ IN CONVENZIONE
La bonanza privata
da il manifesto
In questi anni la sanità pubblica è stata massacrata dai tagli delle finanziarie e dalla riduzione dei trasferimenti alle regioni che hanno la responsabilità di organizzare e pagare i costi delle strutture e dei servizi sanitari. A questi tagli si è fatto fronte riducendo i servizi oppure introducendo e facendo lievitare il costo dei ticket. La sanità privata - convenzionata con il pubblico o sussidiata in altre forme - non è stata sfiorata in questi anni dagli interventi di revisione della spesa e dei contributi. Non si tratta ovviamente di ridurre i servizi a favore dei cittadini, ma di rendere più congrue (e meno lucrative) le tariffe rimborsate (i DRG) ai privati e porre un freno agli abusi di interventi spesso non necessari (abbiamo una delle percentuali più alte in Europa di parti cesarei fatti in strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale) ma che, essendo rimborsati dal servizio sanitario, si sono moltplicati urbi et orbi, alimentando spesso anche il circuito del malaffare tangentizio (come si è visto nel caso della sanità privata in Lombardia). Una semplice revisione delle convenzioni (e delle tariffe, con una limatura media del 10%) con le strutture private ed un sistematico controllo della congruità di una serie di esami ed interventi - il cui eccesso balza agli occhi ad un semplice confronto con gli altri paesi europei - porterebbe da subito, secondo una stima della campagna Sbilanciamoci!, ad un risparmio di circa 1miliardo e 200milioni. Soldi risparmiati che potrebbero essere investiti nella medicina preventiva e territoriale, largamente deficitaria in Italia (e la cui assenza comporta poi maggiori costi umani - e non solo - in termini di «mortalità evitabile» e di interventi e servizi ex post).